 Per farsi una idea di cosa sia il birrificio scozzese Brewdog credo sia sufficiente vedere la grafica del sito e leggere come loro stessi descrivono le loro birre: “Rock’n’roll american session ale”, “Iconoclastic amber ale”, “Post modern classic pale ale”, “Twenty first century black ale”, “Explicit imperial ale”, “Intergalactic fantastic oak aged stout” e via cazzeggiando.
Per farsi una idea di cosa sia il birrificio scozzese Brewdog credo sia sufficiente vedere la grafica del sito e leggere come loro stessi descrivono le loro birre: “Rock’n’roll american session ale”, “Iconoclastic amber ale”, “Post modern classic pale ale”, “Twenty first century black ale”, “Explicit imperial ale”, “Intergalactic fantastic oak aged stout” e via cazzeggiando.
Non bastasse, potrei ricordare le boutade degli scorsi anni, partendo dalle IPA in viaggio per due mesi sull’Oceano, passando alla birra chiamata Speedball e alle conseguenti polemiche, per arrivare alla gara con i tedeschi di Schorschbock per stabilire il vincitore del dubbio titolo di birra più alcolica del mondo (terminata ovviamente con la schiacciante vittoria degli scozzesi, grazie alla sobrietà della “End of the history” venduta all’interno di uno scoiattolo o di un ermellino imbalsamati; n.b.: gradazione di 55% e prezzo da 500 a 700 sterline!).
 Potrei scrivere anche che Brewdog non si è fatta mancare le ormai canoniche birre tirate in serie limitata e le altrettanto obbligatorie collaboration beer con altri birrifici in voga, le baruffe con il partito dei tradizionalisti della birra inglese (il solitamente santificato CAMRA), i video Beer Golf, in cui prendevano a mazzate lattine e bottiglie dei produttori di birra-spazzatura mainstream. Eccetera eccetera.
Potrei scrivere anche che Brewdog non si è fatta mancare le ormai canoniche birre tirate in serie limitata e le altrettanto obbligatorie collaboration beer con altri birrifici in voga, le baruffe con il partito dei tradizionalisti della birra inglese (il solitamente santificato CAMRA), i video Beer Golf, in cui prendevano a mazzate lattine e bottiglie dei produttori di birra-spazzatura mainstream. Eccetera eccetera.
Potrei scrivere ancora tanti eccetera, ma al netto di tutto l’hype resta il fatto che un birrificio nato dall’idea di due amici (James Watt e Martin Dickie) nel 2006, che ha prodotto le prime birre nel 2007, che ha venduto al pubblico 10.000 quote societarie nel 2009 e che ha iniziato ad aprire pub di proprietà nel 2010, è oggi un marchio ben noto in tutto il mondo nel circuito degli appassionati e non solo, che sforna circa un milione e mezzo di bottiglie l’anno e le esporta a più non posso.
Dire quindi che la strategia del casino mediatico è servita ad ottenere un successo strepitoso è quasi un understatement, ma ricondurre questo trionfo alla sola abilità di marketing sarebbe ingiusto e riduttivo: in Brewdog, con gli alti e bassi del caso e facendo la tara agli estremismi fini a sé stessi, se e quando vogliono, le birre le sanno fare!
Certo, gran parte della fama del birrificio deriva da una serie di prodotti “famolostrano” (a parte quanto già ricordato, cito a caso la serie Paradox, passata in botti di whisky, e la Nanny State, da circa 1% di grado alcolico), ma credo che un grande merito degli scozzesi sia l’essere stati tra i primi della nuova ondata dei birrifici indipendenti / di qualità (chiamateli come volete, ma vi prego non “artigianali”, che è una parola che non ha più alcun senso) a tenere un prezzo medio accettabile, ad entrare nel circuito dei supermercati e a sdoganare la lattina come contenitore per un prodotto non dozzinale: oggi è possibile andare al Carrefour e trovare, accanto alle abominevoli Nastro Azzurro e alla esose Baladin, le latte della Punk IPA a meno di tre euro. Certo, a me sembra solo parente della birra dei primi tempi, e molto probabilmente è pastorizzata o perlomeno filtrata pesantemente, ma è comunque più che potabile in relazione al prezzo.
Il proposito dei prossimi giorni è dunque quello di comperare le Brewdog che trovo al supermercato ed assaggiarle per voi. Vedremo assieme cosa ne esce.


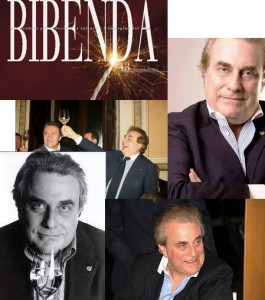



 Rudolf Steiner si è occupato di filosofia, di pedagogia, di esoterismo, di sociologia, di antropologia, di musicologia.
Rudolf Steiner si è occupato di filosofia, di pedagogia, di esoterismo, di sociologia, di antropologia, di musicologia.
